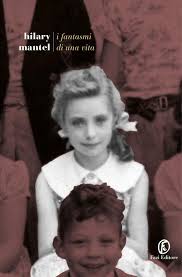Ho incontrato Hilary Mantel una domenica mattina di fine estate. “Robinson”, il sorprendente inserto di Repubblica che riesce nell’impresa di pubblicare nelle stesso numero Emmanuel Carrère e Nino D’angelo, aveva dedicato la copertina a quella che per me era una perfetta sconosciuta. Di lei non avevo letto neppure una riga. Peggio, non sapevo neppure chi fosse.
Per ragioni che mi sono del tutto sconosciute ho un po’ di problemi con le persone obese. Provo nei loro confronti un’avversione ingiustificata quanto profonda, la stessa che anima il gesuita nei confronti del selvaggio che pur privo del Dio cristiano si mostri felice della sua placida ignoranza; una spiegazione la potrebbe dare Susan Sontang nel suo “Malattia come metafora”: la malattia come colpa, la malattia come lato oscuro della nostra coscienza. Così l’obesità, la grassezza, la cicciosità bulimica, l’orrida pesantezza del corpo goffo e deforme, sono la conseguenza della concupiscenza, dell’amore sfrenato per il cibo e per le ghiottonerie. Una fantasia perfetta per tutti gli ipocondriaci e non che nel fondo del loro animo sono convinti che sì, basta “comportarsi bene” per restare in salute. Insomma, il trionfo del “te lo sei cercato e ora adesso che vuoi”. Un’imbecillità nevrotica la mia che le vicende trasformate dalla Mantel in memoria avrebbero immediatamente sopita.
Hilary Mantel è obesa. Forse, come suggerisce la pelle tesa del volto e gli occhi di vago sapore basedoviano, più gonfia che obesa; le foto che l’inserto pubblica lo rivelano con spietatezza enfatizzata da una mise che non fa onore al suo sarto. Sempre che la signora Mantel abbia un sarto. Forse se ne frega del su misura e compra gli abiti a caso. Non è un dettaglio insignificante, affatto. Ma anche questo l’ho capito dopo. Eppure, nonostante la mia imbecillità nevrotica, ho iniziato a leggere l’intervista. Forse non avevo nulla di meglio da fare. O più certamente nell’attesa di uscire di casa (sono sempre il più rapido ad essere pronto). Sono bastate dieci righe d’intervista, più o meno mezza risposta, e ho compreso d’aver incontrato una persona di grande intelligenza. Dopo altre dieci righe ero giunto alla conclusione che sì, avrei dovuto leggerla.
Chi mi conosce sa che detesto la letteratura dei contemporanei. La mia regola è di leggerli da morti. Preferibilmente privi di qualsiasi riconoscimento o menzione letteraria: Campiello, Bancarella; Strega, Pulitzer, Nobel, eccetera eccetera? No, grazie. Non fa per me. Anzi, i premi sono garanzia di caducità, di mediocrità pompata ad arte dall’orrido marketing editoriale. Ho sempre fatto così e vi assicuro mi sono trovato benissimo (disclaimer: ho sempre letto benissimo). In ogni regola ci sono le eccezioni. Ad esempio la meravigliosa e inimitabile Wisława Szymborska, letta da viva, prima, durante e dopo il Nobel; la straordinaria e (per me) inattesa Alice Munro (idem). Nell’elenco c’è molto altro, lavori come il memoir “Il bambino nella neve” di Wlodek Goldkorn. Lo accosto senza timore alle due gigantesse. L’autore non ha per il momento vinto il Nobel e dubito che l’otterrà in futuro, ma il suo è un piccolo grande libro che amo citare con gratitudine per un’infinità di motivi. Qualcuno di essi lo si ritrova nelle “Passeggiate nel bosco narrativo” di Eco; il più importante riguarda ancora una volta l’evento centrale del Novecento, il mistero irrisolto della Shoah.
La faccio breve e vengo al dunque. Il libro che ho dovuto leggere s’intitola “I fantasmi di una vita”. Nelle sue pagine tra molto altro c’è la spiegazione dell’obesità della Mantel. La causa sta nell’orrido sistema sanitario britannico e nella superficialità deficiente di alcuni (più di uno) medici: una malattia non diagnosticata l’ha costretta prima alla sterilità e poi all’incontrollabile crescita ponderale. Hilary Mantel non potrà avere i figli che desidera e a cui ha dato il nome. E’ una vittima dell’englishness quanto della sorte. Ma questo, va da sé, non è motivo sufficiente a giustificare una scelta di lettura: il mondo è pieno di ottime persone che sentono l’esigenza di mettere per scritto le loro sfortune. Purtroppo per loro e per la carta sempre più stanca, la sfortuna non basta. Ovidio langue al confino, Melville alle dogane, Proust pubblica perché è ricco di suo. Ma sfortuna, avversità e miseria anche se fossero necessarie non sono sufficienti: ci vuole talento oltre ad una storia da raccontare. Quella di Hilary Mantel mi è parsa una scrittura bellissima. Ho potuto leggerla in traduzione: chissà che meraviglia nella sua lingua originale. E’ una storia di sopravvivenza come recita un commento in quarta di copertina. Di come nonostante tutto, famiglie disfunzionali, società ottusa, ambiente censorio e meschino, medici abbietti e incapaci, si riesca non solo a sopravvivere ma anche, come accade alla Mantel, a vivere e a fiorire. E’ un libro sulla perdita. Scritto da una donna il cui coraggio rasenta la crudeltà. Forse solo le donne sanno scrivere della perdita in questo modo.