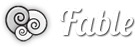Terminato di leggere “Uno scrittore in guerra”, volume che si basa sui taccuini di guerra, saggi e lettere indirizzate alla famiglia di Vasilij Grossman negli anni che vanno dal 1941 al 1945. Dobbiamo essere grati ad Adelphi per iniziative editoriali di eccezionale livello qualitativo, quanto di limitati riscontri di vendite. E a scanso di equivoci, diciamo subito che è questo e non altro il mestiere dell’editore di qualità. (Iniziative che fanno perdonare le spudorate affermazioni del patron Calasso, finalmente atterrato lui pure sul pianeta Terra, che lungi dal riconoscere come tali le sacrosante iniziative commerciali che tengono in piedi una casa editrice e le consentono di pubblicare capolavori destinati a restare di nicchia, ha la faccia tosta di definire il Simenon dei romanzi di cui ha l’esclusiva per l’Italia, “uno dei più grandi scrittori del Novecento”.)
Chi ha avuto il coraggio e la fortuna di leggere “Vita e destino”, il romanzo fondamentale di Grossman meritoriamente pubblicato sempre da Adelphi, ha compreso immediatamente di trovarsi di fronte all’equivalente novecentesco di “Guerra e pace”, un capolavoro assoluto di dolorosità assolute: l’orrore staliniano, l’insensatezza della burocrazia sovietica, i massacri della belva hitleriana, l’occupazione, gli sterminii di massa, Auschwitz… La sintesi del Novecento, il grumo indistricabile di speranze, sogni, idealità, tradimenti, terrore e ferocia.
Leggere oggi “Uno scrittore in guerra” credo abbia un duplice significato. Da un parte incontrare la scrittura di un uomo puro, incorrotto dallo stalinismo, un testimone del suo tempo che rischia la vita per raccontare ai lettori del suo giornale Stalingrado dal vero; e la rischia doppiamente, chè gli appunti dei suoi taccuini non tacciono le nefandezze compiute dai generali sovietici, la loro approssimazione, incapacità, l’obbedienza cieca agli ordini di Stalin che costarono milioni (sì, milioni) di perdite nelle sacche della Wermacht. Conformismo e impreparazione, ottusità e ferocia, che fanno da contraltare all’incredibile coraggio, amor di patria e capacità di sopportazione dell’Armata Rossa e della popolazione sovietica.
Scrivere la verità, annotare che anche i soldati sovietici una volta ribaltate le sorti della guerra si abbandonano agli stupri e ai saccheggi, significava rischiare la fucilazione per tradimento dall’onnipresente NKVD, la polizia politica di Lavrentij Berija.
Scrivere delle terribili responsabilità degli ucraini e dei bielorussi nei confronti degli ebrei, del ruolo svolto da parte della popolazione locale nell’affiancare SS ed esercito tedesco (sì, anche la Wermacht, non solo le SS) nelle liquidazioni di massa, era impensabile e vietato nella Russia sovietica: i morti secondo Stalin non dovevano avere etnia o nazionalità.
Scrivere per primo di Treblinka, scoprire quello che in Occidente si presumeva sin dal ’38, l’orrore dei campi; intervistare di persona i pochi superstiti e i testimoni, è il compito immane e doloroso a cui Grossman non vuole sottrarsi, lui intellettuale ebreo di Berdicev che ha perso la madre nei massacri della città nei primi tragici mesi di guerra quando i tedeschi giunsero alla periferia di Mosca in vista delle guglie del Cremlino.
Il secondo motivo che fa della lettura di “Uno scrittore in guerra” un atto dovuto, è il lavoro di riflessione. Su noi stessi, sull’Europa, sull’idea di Europa. Avrei voluto trascrivere alcune testimonianze sull’occupazione dei soldati tedeschi nei villaggi contadini in Ucraina. Nulla di particolarmente efferato. Tutto incredibilmente bestiale: il loro modo di mangiare con le mani, ubriacarsi, ruttare, fare gare di flatulenze. L’abitudine di defecare sui gradini delle isbe, nudi, totalmente incuranti della presenza altrui, di donne, giovani, bambini. Il comportamento di chi considera l’altro non-umano, sub-umano, se non semplicemente bestiale. (Il commento delle vecchie contadine che Grossman riporta, donne spesso analfabete: hanno sporcato tutto. E noi che credevamo i tedeschi un popolo colto. E’ questa la loro cultura, la cultura di Hitler?).
Il racconto di Grossman ci riporta inevitabilmente al grande insolubile mistero. Non è la Shoah, la riduzione dell’altro a non-umano, a schiavo da sfruttare sino allo sfinimento. Il mistero sta nella premessa affinchè la Shoah si compia: la caduta della Germania, la nazione più evoluta, più sviluppata, più colta d’Europa e forse del mondo di allora, nel più orribile, nel più spaventoso medioevo. Come è stato possibile, come è accaduto, come è stato permesso che accadesse?
A questo Grossman ci fa pensare raccontando cos’è la guerra. Cosa sia stata quella guerra, se possibile la più disumana di tutte le guerre umanamente pensabili. Non ci sono risposte, nessuno ne ha. Ma smettere di interrogarsi è il miglior modo per far sì che l’abisso possa spalancarsi di nuovo.