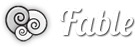Qualche sera fa per la serie “La lezione dei maestri” di Rai 5 c’era Eva Cantarella. Ripresa tra le aule della Statale e il suo studio spiegava perché è importante studiare il mondo antico. Oltre a mille altri buoni motivi sosteneva che “aiuta a relativizzare i fenomeni del nostro tempo insegnandoci che, sotto altra veste, sono già accaduti”. Ovvero, la storia si ripete; e le scelte che crediamo epocali, come pure i nostri umani affanni, qualcun altro ha dovuto affrontare e magari subire. (Relativizzare è un esercizio di virtù stoica che andrebbe insegnato già dalle elementari).
Poiché la penso come Eva, la conobbi tanti anni fa quando ebbi la fortuna di correggere le bozze del suo “Norma e sanzione in Omero”, non riesco a fare a meno di testi squisiti e ahimè non di così facile lettura come invece il titolo lascerebbe supporre (“I greci hanno creduto ai loro miti?”, il Mulino). L’autore è Paul Veyne, il più importante studioso di storia romana, membro di quell’Académie che essa sola già basterebbe a rendere infinito il debito di riconoscenza che abbiamo nei confronti della terra di Francia.
Leggere questi lavori di Paul Veyne non è una passeggiata: l’autore non intende scrivere un manualetto di vita greca (pensavano così, ma anche cosà) bensì di interrogarsi sul rapporto che allora come oggi gli esseri umani senzienti hanno con il racconto, la leggenda, la fiaba, piuttosto che il mito. Ovvero ragionare sulla poesia, la letteratura, l’arte e il teatro. E quindi di chiedersi come si chiede e ci chiede se, quando leggiamo Cervantes piuttosto che Shakespeare (o l’Odissea) e siamo dentro l’opera, se ci confondiamo insieme ad essa, e troviamo perfettamente credibile che Odisseo, ad esempio, debba misurarsi con il Ciclope e il Cavaliere della Mancia coi mulini a vento. Perché nell’hic et nunc della lettura, la finzione diviene realtà, gli dèi veri e verosimili, e il mito perfettamente sensato. Di più: indispensabile. Poiché senza di esso la macchina narrativa non funzionerebbe affatto. E questo accade non solo nel confronto con i grandissimi, ma pure con Salgari e la signora Rowling: alzi la mano chi non si è sentito almeno una volta tigrotto insieme a Sandokan e Yanez.
Il focus di Paul Veyne si sposta costantemente dagli Antichi a noi, dalla loro sensibilità alla nostra; fermo restando che tra la loro e la nostra ci separano non solo la bellezza di 2500 martoriati anni, quanto la forza devastante della rivoluzione (delle rivoluzioni) scientifiche. Le sole, le vere responsabili, della morte del mito e della distruzione del recinto del sacro.
Questo beninteso non significa che noi “moderni” siamo approdati alla razionalità. Il postulato “tutto ciò che è reale è razionale e viceversa” è una delle più grandi puttanate nella storia del pensiero umano d’autore. Per convincersene non occorre aprire il giornale, basta sporgersi oltre la finestra di casa. (Nel dubbio, provate a chiedere ai discepoli dell’oroscopo su quale sistema astronomico si basino i segni zodiacali e le “previsioni”; sono certo che nessuno di loro sa che il riferimento è ancora l’astronomia di Tolomeo, quella tanto amata dalla Chiesa con la Terra al centro e il Sole a girarci intorno).