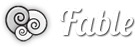Una delle poche cose carine di quest’estate così avara di sole sono stati i programmi di Rai Storia, il solo canale televisivo che mi faccia venir voglia di pagare il canone. Tentazione che continuo a contenere con pacata serenità: sloggino i politici, si venda una rete e dopo magari ne riparliamo.
In una delle molte sere d’agosto tormentate dai temporali, la prima serata di Rai Storia è stata dedicata ai torbidi amori della Duse e del signor Rapagnetta, più noto come D’Annunzio, nome d’arte che assunse da un ricco parente.
La ricostruzione di Rai Storia, al solito accurata, racconta come il Rapagnetta usò la più grande attrice europea per entrare in un mondo, quello del teatro, che gli era sconosciuto e precluso. Usò la sua fama, il suo talento, il suo denaro. Come contropartita la umiliò sistematicamente in tutti i modi possibili: sessuale, artistico, affettivo. Le lettere della Duse, sola e ammalata, sembrano tratte da un’edizione postuma del libro “Cuore”: lo chiama “figlio” (forse per via del gap anagrafico?) e gli rimprovera malefatte – sostanzialmente e banalmente si tratta di corna perpetrate nella villa toscana acquistata grazie ai soldi di lei – che lui giustifica chiamando in causa la sua naturale vitalità; versione piuttosto banale del classico l’omo è cacciator.
C’era da aspettarsi di più e di meglio dal Rapagnetta? Quando la Duse morì sola in America dove si era recata in tournee per tentare di raccattare un po’ di denaro, il nostro scrive un’intemerata al Duce intimandogli di pagare le spese per il rientro in patria della salma e un giusto funerale. Lui nel senso di noi, beninteso, lo Stato. Che è poi il più autentico dei topoi dannunziani: io spendo e voi pagate i debiti.
Lo speciale di Rai Storia è come sempre ricco di documentazione fotografica e in pochi tratti si ha il senso di un’epoca e di una civiltà. Così, è forse inevitabile confrontare il percorso mondano di D’Annunzio, i suoi inizi di cronista gossiparo della nobiltà romana e la progressiva scalata sociale, con quello compiuto da Proust in Francia o da Mann in Germania. (Per tacere dell’incredibile clima nella Vienna di inizio secolo, quando letteralmente presero vita come un’esplosione tutte le tendenze culturali che oggi chiamiamo moderne; filosofia, psicologia, logica, pittura, musica, architettura. E letterati del calibro di Schnitzler, Werfel, Roth, Musil, Kraus.)
Anche Proust frequenta il bel mondo dei Faubourg. Anche Proust scrive di mondanità assortite sui giornali dell’epoca, mentre il giovane Mann studiava per diventare autorevole, riuscendoci perfettamente, come raccontano le foto d’epoca mostrandocelo impettito in redingote. Autori che assumono in Francia e in Germania e poi rapidamente in tutto il mondo il primato che la storia della cultura novecentesca riconosce loro: l’inventore di un genere inaudito Proust, che con la sua cattedrale trasforma per sempre il concetto di “romanzo”; un “classico” fin dagli esordi Mann (pensiamo alla perfezione formale dei I Buddenbrook) oltreché un supremo interprete della crisi europea.
Cosa resta di Rapagnetta–D’Annunzio, dal 1924 divenuto Principe di Montenevoso? Al solito, molta confusione. Da parte di chi confonde, come capita assai spesso, tra il peso sociale e di costume e l’autorevolezza creativa; tra la capacità di segnare il gusto di un’epoca e l’effettivo ruolo storico-artistico.
Nella piccola, modesta italietta, paese di contadini analfabeti, Rapagnetta contrassegna lo chic dell’epoca e gioca lo shock. Inventa mode, parole, costumi. Decide cosa sia in e cosa out. Cavalca gli eventi o li crea a bella posta con impeto situazionista. Dona ad un paese arretrato e provinciale il frisson della trasgressione, del peccato, della volontà di potenza, del gusto della vita che sfida la banalità e la morte, compilando con astuta maestria il disegno di un’esistenza “unica e inimitabile” che lo porterà alla responsabilità non piccola di aver legittimato il fascismo e contribuito a consegnare il paese alla dittatura.
Cosa resta dopo il fuoco fauto del bric-à-brac che affastella parole, oggetti, azioni e pose? Il trovarobato del “Vittoriale”, capolavoro del kitsch nostrano eretto a Gardone Riviera. Il mito dell’eroe, dell’azione, della guerra purificatrice, del sangue purificatore agognato dai deliri dei futuristi. Insomma, la guerra moderna apparecchiata dai soliti vecchi mascalzoni dove a morire andranno solo i giovani. E pagine imbarazzanti, ridicole sino a risultare illegibili.
Il vero segreto, il più profondo e insondabile, è tuttavia un altro. Perché mai in ogni epoca, civiltà e paese, donne di grande valore e talento continuano a consegnarsi mani e piedi legati a uomini piccoli, meschini e pure fisicamente ributtanti? Mistero.