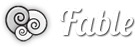L’altra sera ha vinto la vergogna per un’inerzia che sborda abbondantemente nell’accidia. Così mi sono dato una mossa e ho prenotato lo spettacolo delle 21 al cinema Plinius. Sala pressoché vuota, buon segno: saremo stati in una trentina alla proiezione de “Il giovane favoloso”. Progetto da far tremare le vene e i polsi, un film sulla vita del più grande poeta moderno italiano: siamo matti?
Diciamo subito che il film regge a fatica il lungo arco delle due ore e mezza. E che regge per la mostruosa abilità dell’attore protagonista. Elio Germano riesce a regalarci un Leopardi vero e credibile dall’età dell’adolescenza sino alla morte, costringendoci al dolore dell’immedesimazione e dell’empatia, del riconoscimento e della ribellione, della disperazione senza via di salvezza per le sofferenze che la vita (sotto specie di due genitori patologicamente perversi quali furono il conte Montaldo e la maledetta di lui moglie, l’orrida Adelaide Antici Leopardi) hanno inflitto al più straordinario pensatore dell’Ottocento italiano.
Un pensatore che, al di là delle inevitabili difficoltà di una lingua raffinatissima ma inevitabilmente a noi lontana, appare quale nostro perfetto contemporaneo: anticipatore di larga parte del pensiero filosofico novecentesco (ricordo che Leopardi morirà nel lontano 1837) le sue riflessioni sull’esistenza e sulla condizione umana non sono state scalfite dal tempo.
Il miracolo del film è il dolore di Giacomo reso dalle scelte di regia attraverso immagini esemplarmente simboliche della sofferenza che porta fuori di sé: Giacomo accucciato sulle ginocchia che si dondola con fare autistico; Giacomo che scalcia la terra e la percuote con un bastone nel parossismo di una crisi di furore e sgomento; Giacomo abbandonato sulla riva dell’Arno come fosse stato colpito a morte dalla consapevolezza che a lui, il genio totale, Eros sarebbe sempre stato negato. Il dolore. La solitudine. La consapevolezza del dolore e dell’assenza della sola felicità capace di consolare dal peso dell’umana esistenza: il dono dell’amore, dell’amare e dell’essere amati, il solo sentimento che può dare senso all’esistenza e rendere sopportabile l’idea della morte, della nostra caducità, del nostro inevitabile disparire. Un dono che a lui, goffo, gracile, malato, sarebbe stato negato.
E insieme a questa quasi insopportabile consapevolezza dell’essere gettati in un mondo senza amore, la coscienza – perfetta – che l’infelicità è lo stato naturale della condizione umana, persino se si è giovani, se si ha la ventura di essere belli, desiderati, amati. E che l’unica età felice è quella dell’infanzia e della spensieratezza.
Giacomo non scrive dell’infelicità e della melanconia perché gobbo, deforme e malato- è questa la più straordinaria delle volgarità che ci vengono instillate dall’età della scuola media in avanti – ma perché questa e non altra è la condizione umana. Dove il vero nemico non è, non può essere, un altro uomo o un gruppo di uomini, bensì la Natura stessa, cieca, caotica, indifferente. (Un’intuizione che il giovane Marx coglie immediatamente quando teorizza l’inizio della storia con la fine delle contraddizioni fra classi e uomini, laddove il confronto autentico, e quindi la vera lotta, è tra uomo e natura).
Il dolore di Giacomo, la sua solitudine, la beceraggine dei letterati filistei, i modesti personaggi che animano la vita culturale dell’italietta dell’epoca, che non comprendono e mal sopportano, e poi non sopportano più del tutto, la grandezza del piccolo uomo deforme.
E la coglioneria di Ranieri, il vagheggino napoletano, che ha avuto l’onore e la fortuna immensa di vivere accanto ad un genio (il badante di un uomo difficile e indubbiamente faticoso da reggere). Ma possibile che di tutti i discorsi, le riflessioni, i pensieri, i ripensamenti, che ha avuto la fortuna di ascoltare di persona, il modesto Ranieri ci abbia ha lasciato solo un misero libretto di ricordi che farebbe arrossire persino il direttore di “Chi”? (Stai al fianco di Mozart, di Einstein o di Platone, ne condividi la vita, i patimenti e i pensieri; vedi nascere il fiore della lirica italiana, ne segui passo passo il percorso, la trascrivi in bella copia persino, e ciò di cui sai dare testimonianza sono la ghiottoneria per il gelato e le mutande sporche?!?!).
Sappiamo chi ci ha messo la faccia, ma mi domando chi abbia chi ci abbia messo i quattrini: chapeau. Il cinema italiano, pur così insopportabilmente zeppo di guitti che berciano sempre lo stesso copione vuoto di idee, non è del tutto morto.