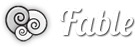La scorsa notte, o forse era l’altra ancora, leggendo “La terra di Ulro” di Czeslaw Milosz, uno dei molti motivi per cui dobbiamo portare gratitudine all’Adelphi di Galasso nonostante il fastidio quasi fisico che il suo algido patron suscita, mi sono imbattuto in una citazione di Holderlin.
Ne so abbastanza poco riguardo a questo poeta tedesco, vita sfigatissima, tanto per cambiare; il bello della lettura, quella autentica intendo, sta proprio in questo: seguendo una traccia se ne incontra un’altra e poi un’altra ancora, e così (quasi) all’infinito. Se si ha la curiosità e la pazienza di seguirle, si scopriranno una quantità di connessioni che costituiscono la trama e l’ordito della tela – solo apparentemente invisibile: in realtà solida più dell’acciaio – che costituisce ciò che per semplicità chiamiamo struttura culturale.
Milosz cita il motto preferito di Holderlin (dico “preferito” poiché sono certo che ne avesse più d’uno appartenendo egli al mondo che, insieme a quello francese, più e meglio di chiunque altro ha praticato l’arte dell’aforisma). Il motto recita “Gerarchia, fraternità, libertà”. Non si tratta di una dichiarazione politica, ma di un enunciato della repubblica delle scienze e delle arti, come acutamente segnala Milosz.
Il sostantivo gerarchia, che mi viene spontaneo accostare a distinzione, mi è tornato in mente diverse volte in questi giorni di dolore. Gerarchia dei valori, dei significati, dei primati e dei principi. Gerarchia delle opere, delle scoperte e delle scienze. Ma anche gerarchia dei sentimenti e delle emozioni. Senza adeguato esercizio di gerarchizzazione (ovvero di distinzione) si rischia di scivolare nella parodia. E nella parodia della parodia. L’esercizio inconsapevole e spesso persino involontario, in cui si esercitano incessantemente i populismi di destra come di sinistra. Insopportabile in tempi normali, inudibile nell’età del dolore.
Così, seguendo la traccia di un’altra traccia, sono giunto sino ad una poesia di Holderlin. Si intitola “Ricordo”. Ci porta sulle rive della Garonna cui approdai tanti anni fa nel corso di un viaggio che avrebbe dovuto condurmi a Finisterre e terminò invece nel quartiere della Défense a Parigi. Correva l’estate dell’anno 2000. L’autunno sarebbe stato orribile ma ancora non lo sapevo.
Andeken (Ricordo)
È il vento di nord est.
Il più amato dei venti
per me, perché ai marinai promette
la rotta giusta e l’anima ardente.
Va’ e saluta
la bella Garonna
e i giardini di Bordeaux
là dove il sentiero
s’accosta alla riva aspra
e il ruscello cade profondo
nel grande fiume
ma sopra
è in vedetta la nobile coppia
delle querce e i pioppi d’argento –
io mi ricordo
ancora del bosco d’olmi
che china le larghe cime dei monti
sul mulino, ma nella corte
cresce la pianta del fico.
Nei giorni di festa
vanno le donne brune
sopra un piano di seta,
al tempo di marzo,
quando uguali son la notte e il giorno,
e sui sentieri lenti
carico di sogni d’oro
passa ondoso il respiro del vento:
ma mi si offra quella coppa inebriante
colma di luce bruna
perché possa riposare:
dolce sarebbe
sotto le ombre il sonno.
E male è se l’anima si perde
lontano da pensieri di mortali.
Bene è invece parlare,
dire i pensieri del cuore,
udir molte cose
dei giorni dell’amore,
dei fatti che avvennero.
Ma gli amici, dove sono?
Bellarmino e il suo compagno?
C’è chi ha timore
ad andar alla fonte.
Ma la ricchezza ha inizio
nel mare. Essi come pittori
raccolgono tutta la bellezza
del mondo e non spregiano
la guerra alata, avere
la casa sotto un albero senza fronde,
per anni, solitari,
dove la notte non ha luci
di città e di feste
né musiche né danze native.
Ma ora quegli uomini sono salpati
per le Indie, nel promontorio arioso
presso le erte vigne
da cui la Dordogna scende
e insieme alla Garonna sfarzosa
esce fiume ampio come mare.
Il mare dona e toglie il ricordo;
l’amore fissa i suoi occhi fedeli
Ma il poeta fonda ciò che resta.