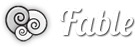Questa è una madeleine particolarmente difficile. Poi non dite che non vi avevo avvertito. Difficile da scrivere, non da leggere spero. Il tema è un libro il cui titolo – “Lettere dal mondo offeso”, L’arcolaio editore – dice quasi tutto, ma appunto non tutto. Si tratta di lettere, certo, qualcuna cartacea, qualche altra digitale, che due persone si sono scambiate colmando 1611.75 kilometri di distanza in linea d’aria. Non si tratta di epistolari accademici tipo Ugo Foscolo – Antonietta Fagnani Arese e neppure del genere ultime lettere della povera Moana Pozzi alla zia Carolina in tema di fede, speranza e carità. (Notare che nel Belpaese record al mondo di ipocriti&corrotti, quando uno muore acquista l’appellativo di povero: il povero qui, il povero là. Non importa siano stati ladri, papponi o mignotte, sempre poveri diventano).
Le lettere in questione (lettere, cartoline, mail) sono quelle che si scambiano due poeti: uno giovane e (per il momento) ancora poco conosciuto; l’altro vecchio e un tempo apprezzato da autori del calibro di Fortini e Porta, ma da sessant’anni relegato fuori d’Italia (1611.75 km in linea d’aria appunto).
Ora in tutta onestà, io non so cosa sia la poesia. E non sono neppure certo di saperla riconoscere a colpo sicuro. A differenza di don Benedetto, il sommo scimunito che più di una responsabilità porta nello sfascio delle culture patrie. Del resto la storia di Chistian Tito e di Luigi Di Ruscio è di quelle che vanno al di là di una banale questione estetica; perchè la poesia, con buona pace di ogni crocianesimo, non è solo estetica, anzi. E’ politica, esistenziale, morale.
Ma chi sono questi due che si scrivono, si scambiano pareri, incoraggiamenti, consigli, affetti?
Uno, Christian Tito, è un farmacista moderno che l’idiozia del solito gruppo multinazionale ha traformato in droghiere che passa le sue giornate tra la scadenza delle supposte di glicerina e la conta dei punti (non quelli di sutura, ma dei buoni sconto) che i clienti più deficienti del circondario s’incistano a fare.
L’altro, Lugi Di Ruscio, è un operaio antico. Di quelli che negli anni ’50 dalle Marche sono dovuti andare sino in Norvegia per trovare lavoro. Operaio metalmeccanico, trentasette anni passati a fare chiodi.
I due si scrivono:
“Caro Christian dovevi essere molto giovane quando tuo padre è morto. Le fabbriche ovunque possono essere dei luoghi davvero infernali, lo strano è che chi la vive da dentro non parla mai di quell’inferno mentre chi sta fuori ne parla moltissimo pur non sapendo niente”.
“Caro Luigi, ieri sono stato alla presentazione di un nuovo libro. Mi hanno chiesto perchè mai siamo amici. Ho risposto che è una storia strana e bella, affidata tutta alla parola. Poi ho pensato che il perchè dell’amicizia è un dono misterioso. E nel mistero è bello starci senza chiedersi troppo il perchè.”
Un rapporto di fiducia vera: “Caro Christian, ti mando questa poesia dal significato poco chiaro, per carità non farla girare”.
Ho la bocca piena di farfalle
e se apro la bocca voleranno via tutte
e non ritorneranno neppure
se rimango a bocca spalancata
per una eternità.
(La risposta di Christian la trovate a pagina 75. A me pare molto bella e mi fa pensare al secondo principio della termodinamica).
Scrive ancora Di Ruscio: “Sono iscritto al Pci dal 1953. Però non raccontatemi fregnacce, qui qualcosa non quadra, quando vado in sezione a leggere le poesie tutti si mettono a ridere”.
Già, perchè se qualcuno si mette a parlare di poesia la gente (la ggente) sbadiglia, ride o lo prende per matto? Pci, Dc, Psi come allora si chiamavano i partiti?
Perchè lungo tutto il corso del Novecento – che non è affatto un “secolo breve”, anzi: la tragedia è durata un tempo insopportabilmente lungo – la distinzione è sempre tra rispettabilità borghese e malattia d’artista, tra ordine e caos dionisiaco, tra ispirazione (dell’artista) e traspirazione (dell’uomo normale).
L’artista per essere tale deve essere posseduto: dai demoni, dal furore, dagli dèi. E’ “diverso” per definizione: grandezza, sensibilità, malattia (o sensibilità malata). E’ demoniaco come l’Adrian Leverküh del Faustus manniano, o decadente come il ben più modesto Andrea Sperelli. Oppure non è.
Vero è che la ggente, ai primi del Novecento come in mezzo e pure alla fine, di poesia non si è mai interessata perchè la poesia è fatica. Richiede conoscenza, impegno, strumenti interpretativi. Ne aveva rispetto, o forse solo timore, della poesia; quello stesso che impone al contadino di togliersi il cappello davanti al signore. Se e quando la scopriva, è allora che smetteva di essere ggente e iniziava a diventare persona.
(All’Olivetti di Ivrea, la più bella esperienza di cultura industriale del nostro paese di cui non si parla mai abbastanza, chè l’Olivetti e in particolare l’Adriano Olivetti stava sullo stomaco pressocchè a tutti in quegli anni: al Pci di Togliatti come alla Dc di Fanfani, ai laici come alla Chiesa; all’Olivetti dicevo, c’era una biblioteca con libri, riviste e giornali a disposizione di tutti in fabbrica; e il cineforum con pellicole di prima, sempre affollato. La ggente di Olivetti faceva in fretta a diventare persona. Era questo forse che non piaceva: la ggente si manovra e si manipola, le persone meno).
Al termine della seconda guerra mondiale, ammesso che sia mai terminata, le macerie del secondo grande disastro attizzato da noi europei erano tali che il superomismo artistico non era più sostenibile e forse per un po’ la dose ci sarebbe bastata. Caduti gli dèi nibelunghi, morti e sepolti anche i cascami dannunziani, “fare poesia” diventa un mestiere da conventicola occulta, una pratica che si manifesta con discrezione e decoro all’interno di una cerchia selezionata e selettiva, un ortus conclusus dove i poeti leggono (a bassa voce) gli altri poeti. E insieme contendono, discutono, bisticciano, si amano e si detestano con la passione e la ferocia tipica dei circoli intellettuali ristretti. Quanto “tira” un’opera di Raboni o della di lui compagna Patrizia Valduga (debole di mente e bravissima lei, debole di cuore e bravissimo lui)? Quante copie vendono Luzi o Caproni, Bertolucci o addiritura il Nobel Montale? Millecinque, duemila, tremila copie? E stiamo parlando, si badi bene, del Ghota della poesia italiana del secondo Novecento.
I poeti si leggono tra loro. Si incontrano tra loro. Si bisticciano e si odiano tra loro. Si conoscono, come nel caso di Christian Tito e Luigi Di Ruscio, grazie alla tranquilla follia di persone come la Laura, che a Milano in via Cesariano al 7 dà vita alla “Libreria del mondo offeso”, un posto dove – alla facciaccia brutta di Jeff Bezos e dei suoi maledetti algoritmi di lettura – qualcuno (il vero libraio) propone qualcosa di nuovo e sconosciuto, con particolare coraggiosa attenzione alla letteratura italiana. E lì che Christian il famacista incontra la sua droga, l’opera omnia di Luigi Di Ruscio il metallurgico. E da lì che prendono le mosse di queste conversazioni a distanza che solo la morte di Luigi avvenuta nel 2011 concludono.
Concludo anch’io: l’avevo premesso che questa madeleina sarebbe stata difficile. Passati gli effetti della sbornia narcisistico-nicciana, morta e sepolta ogni tentazione di salire sul cavallo bianco sciabola sguainata, la poesia come un angelo decaduto ritornata con i piedi per terra si trova a fare i conti con la normalità: Montale sulla carta d’identità alla voce “professione” recava scritto giornalista; Raboni campava di traduzioni). Una normalità nemica della poesia. Dello studio. Dell’impegno. Del rigore. Del “non importa ciò che fai, ciò che conta è farlo bene”. Una normalità nemica della fatica: la poesia è un’arte faticosa assai, per chiunque la pratichi, da lettore come da autore. Solo la povera Alda Merini era così stupida da affermare che tutti sono poeti. Ma come, ma dove, ma quando? La poesia è la cosa più difficile e selettiva che esista; dài e dài puoi persino imparare a far miagolare il violino; ma se non hai niente da dire, non c’è verso con la poesia. Appunto.
A che serve la poesia allora? E’ un cilicio, un castigo di Dio, un vezzo snobistico per fare casta?
Christian Tito e Luigi Di Ruscio, grandi o piccoli poeti che siano, questo insegnano: la poesia di chi vive la vita reale e sta nel mondo è un antidoto potentissimo contro la bestialità matta e disperata che cova in ciascuno di noi; è il modo di continuare a porsi domande e darsi risposte nel mentre si combatte ogni giorno la più difficile delle battaglie, quella del senso. In fabbrica, in farmacia, all’asilo Vattelapesca o dove volete voi.
Sono pochi, sono permalosi, sono spesso rissosi: ma i poeti non sono più quelli laureati che sbeffeggia il Montale dei “Limoni”. Scrivere sperando di farsi leggere, ma anche no, è il loro modo di dare un senso al tempo, alla vita, allo stare nel mondo. A questo serve la letteratura. Quella che si legge e quella che si scrive. Scusate se è poco.